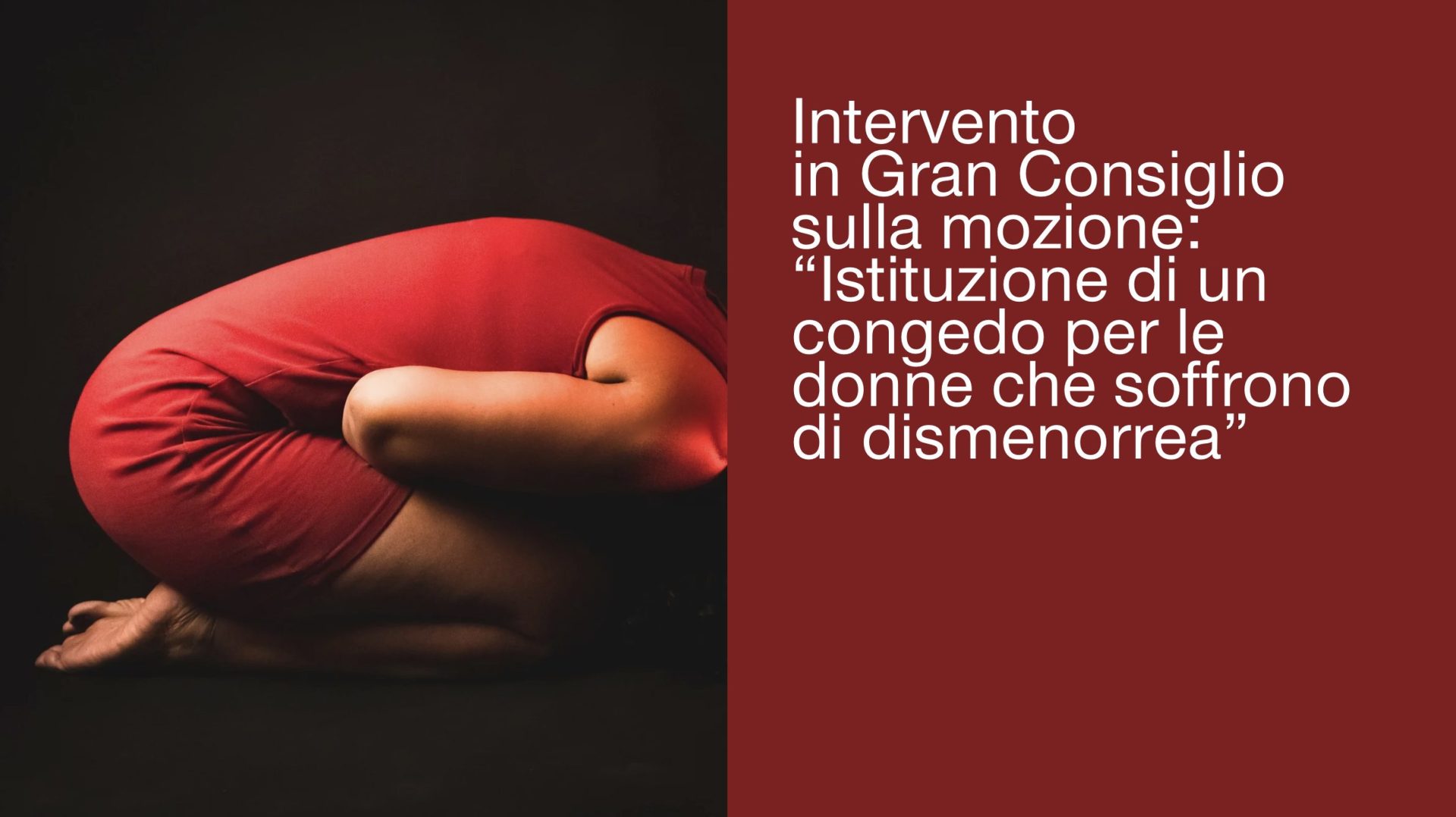Stimati Presidente e vicepresidenti, care colleghe e cari colleghi,
l’oggetto della nostra discussione non concerne un privilegio corporativo particolare, né un cedimento ideologico.
Si tratta, piuttosto, di un atto di riconoscimento: il riconoscimento della realtà fisiologica che riguarda circa metà della popolazione attiva e che il nostro ordinamento, al pari di gran parte delle normative occidentali, ha a lungo relegato all’invisibilità sociale e giuridica. Parliamo del dolore mestruale e del suo impatto sul lavoro, sulla salute, sulla dignità delle donne.
Il rapporto di maggioranza si compiace di un sistema che – cito – “funzionerebbe in modo silenzioso”. Ma è precisamente questo silenzio il problema. Il silenzio che, da secoli, è stato imposto alle donne rispetto al proprio corpo, riducendo un’esperienza fisiologica a un fatto privato, inconfessabile, da sopportare in solitudine.
Questa invisibilità non è affatto neutra: è il prodotto di rapporti sociali e di un sistema economico. Nel capitalismo industriale e post-industriale il corpo femminile è stato inglobato nel mercato del lavoro, soltanto a condizione di uniformarsi al modello maschile, ossia di lavorare come se il ciclo mestruale non esistesse. Il dolore mestruale non è mai stato riconosciuto come legittimo impedimento, perché ammetterlo avrebbe significato incrinare l’ideologia della produttività costante, dell’operaio/operaia-macchina e della neutralizzazione dei corpi.
È vero che il nostro ordinamento prevede oggi fino a tre giorni di assenza senza certificato medico. Ma si tratta di un istituto generico riferito alla malattia. Assimilare la dismenorrea alla “malattia” è una forzatura concettuale.
Questo artificio giuridico produce due effetti distorsivi:
in primo luogo, le lavoratrici sono costrette a consumare giorni di malattia per un evento ciclico, rischiando di rimanere prive di tutele in caso di vere patologie;
in secondo luogo, si perpetua lo stigma, perché l’assenza viene registrata come malattia quando, in verità, la donna non è “malata” in senso clinico.
Il sistema vigente, dunque, non colma il bisogno reale, ma lo maschera, scaricando sulle lavoratrici il costo temporale, simbolico e reputazionale.
Si obietterà che un congedo specifico genererebbe disparità rispetto ad altri disturbi ricorrenti. Ma la dismenorrea non è un’emicrania occasionale né una lombalgia: è legata alla funzione riproduttiva femminile, e in ciò risiede la sua peculiarità. La parità non è identità di trattamento; è equità sostanziale, ossia riconoscimento delle differenze e loro tutela adeguata.
L’ideologia capitalistica tende a universalizzare il lavoratore astratto, neutro, disincarnato. In realtà, quel lavoratore neutro è un corpo maschile eletto a norma.
Il rapporto di maggioranza paventa il rischio che i tre giorni diventino un automatismo, fino a 36 giorni l’anno. Questo argomento si fonda su un presupposto inquietante: che le donne siano inclini a mentire e ad approfittarne.
Io ribalto la prospettiva: il vero abuso è costringere chi soffre a tacere, a lavorare piegata dal dolore, oppure a consumare giorni di malattia che le spettano per altri eventi.
E le esperienze nazionali e internazionali lo confermano: in Spagna, a Friburgo, a Yverdon, così come in Giappone o in Corea del Sud, non si è verificata alcuna “corsa al congedo”. Dove la misura esiste, viene utilizzata con responsabilità e parsimonia.
L’argomento dell’abuso, dunque, non descrive una minaccia reale: descrive una sfiducia di principio nei confronti delle donne.
Forse l’argomento più insidioso è quello che paventa un rafforzamento degli stereotipi di debolezza femminile e un conseguente disincentivo all’assunzione di donne. Ma questa è la logica del ricatto: “non concediamo diritti, perché qualcuno potrebbe usarli come pretesto per discriminare di più”.
La storia insegna che i diritti sociali non si conquistano cedendo a questo ricatto. Lo stesso è stato detto a proposito delle ferie, del diritto di sciopero, della maternità. Eppure, quelle conquiste hanno reso la nostra società più giusta, non meno efficiente. La via non è negare diritti, ma affermarli e rivendicarli con chiarezza, accompagnandoli con regole precise, con vigilanza e con sanzioni contro chi discrimina.
È vero che i Cantoni non hanno competenza sul diritto del lavoro privato. Ma nel pubblico impiego dispongono di ampi margini d’intervento. E storicamente proprio il settore pubblico è stato laboratorio di conquiste: dalle ferie retribuite alla riduzione dell’orario di lavoro, fino ai primi passi verso la parità salariale.
Il Ticino ha dunque la possibilità di assumere un ruolo pionieristico, offrendo un modello culturale e normativo che rafforzi il dibattito nazionale. Introdurre il congedo mestruale nel pubblico impiego significa assumersi la responsabilità di guidare un cambiamento che altrove è già iniziato.
Il congedo mestruale non è soltanto una misura sanitaria: è un passo di emancipazione collettiva.
Significa riconoscere che il dolore femminile non è marginale, né “naturale” da sopportare in silenzio.
Significa legittimare l’esperienza del corpo femminile, sottraendola alla colpevolizzazione e al tabù.
Significa rafforzare la parità, intesa non come omologazione, ma come diritto di essere sé stessi nel mondo del lavoro.
In un sistema economico che misura ogni istante in termini di produttività, questa misura afferma un principio radicale: che la salute, la dignità e l’uguaglianza vengono prima del profitto e della neutralizzazione dei corpi.
Oggi siamo chiamati a decidere se perpetuare il silenzio di un sistema che “funziona” soltanto perché non vede o nasconde il dolore, o se avere il coraggio di guardare in faccia la realtà, di riconoscerla e tutelarla.
Per queste ragioni vi invito a sostenere il rapporto di minoranza e ad approvare la mozione.