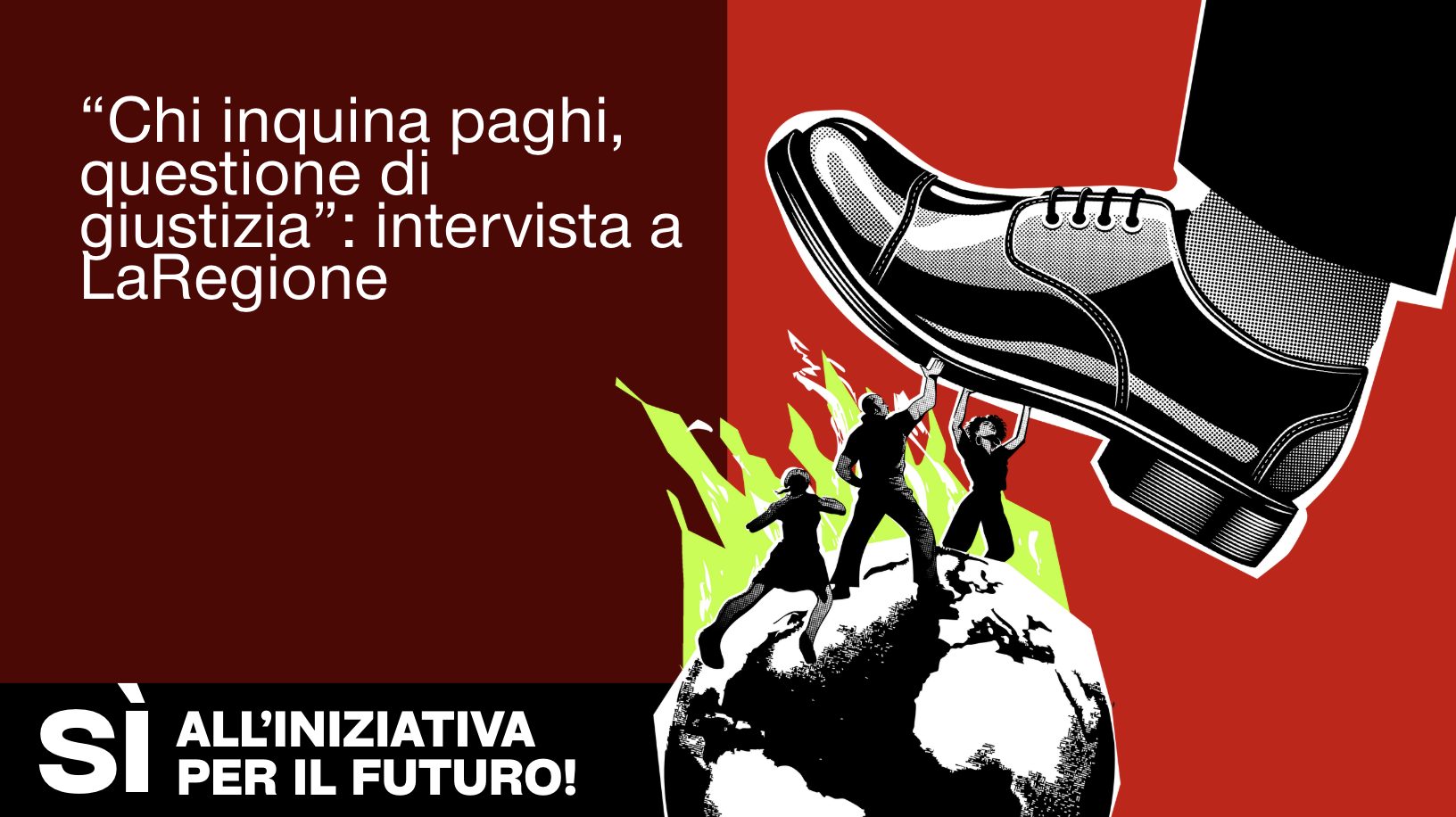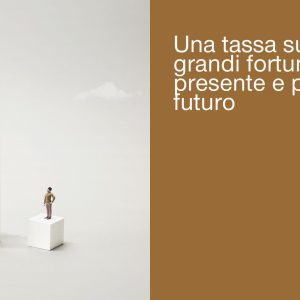- Di Stefano Guerra
L’obiettivo dichiarato della vostra iniziativa è la protezione del clima. Ma allo stesso tempo affermate che “è necessario riformare radicalmente il nostro sistema economico”. L’impressione è di essere ancora alla lotta di classe, al superamento del capitalismo: la vostra non è ottusità ideologica?
Partiamo semplicemente dall’osservazione della realtà: la crisi climatica e la concentrazione della ricchezza. Questi due problemi concreti vanno affrontati assieme. È quanto propone la nostra iniziativa, che permetterebbe di ricavare 6 miliardi di franchi all’anno per finanziare ad esempio programmi per il mantenimento di posti di lavoro e di formazione continua, lo sviluppo della mobilità sostenibile o programmi di risanamento energetico degli edifici.
Ve la prendete con i ‘super-ricchi’ che “minacciano il nostro futuro e la democrazia”: che problema avete con loro?
Non è una questione personale, ma di giustizia. Il fatto è che numerosi studi – il recente rapporto di Oxfam, ad esempio – dimostrano come le persone più ricche siano quelle che inquinano molto di più. Noi perciò diciamo che, in base al principio ‘chi inquina paga’ sancito dalla Costituzione, questi super-ricchi devono contribuire maggiormente alla lotta contro la crisi climatica. Sono sempre loro, poi, a trarre il maggior beneficio dal sistema capitalistico, controllando il potere grazie alla ricchezza. In questo senso, la nostra iniziativa funge da correttivo.
La Svizzera ha già un sistema fiscale fortemente progressivo: il 10% delle persone più ricche garantisce il 90% del gettito dell’imposta sulla sostanza e il 50% del gettito dell’imposta sul reddito.
Nessuno nega che i super-ricchi già oggi contribuiscono in maniera interessante dal punto di vista fiscale. Ma non è sufficiente. Se il sistema fiscale funzionasse a dovere, non avremmo una tale concentrazione della ricchezza. In Svizzera l’1% più ricco possiede quasi il 45% del patrimonio totale; e le 300 famiglie più ricche possiedono 833,5 miliardi di franchi. Dall’altra parte, la stragrande maggioranza della popolazione vede i salari ristagnare mentre i premi di cassa malati e gli affitti aumentano senza sosta.
In Svizzera, i soldi di una famiglia sono già tassati come reddito e come sostanza. Inoltre, siamo tra i pochi Paesi dell’Ocse ad avere sia un’imposta sulla sostanza incisiva, sia imposte (cantonali) sulle successioni. Che bisogno c’è di appesantire ulteriormente la macchina fiscale?
La macchina fiscale non è pesante, ma complicata. La nostra è una delle soluzioni possibili al problema della concentrazione della ricchezza. Ce ne sarebbero molte altre: aumentare un po’ l’imposta sulla sostanza, una micro-tassa sulle transazioni finanziarie, e così via. Abbiamo optato per l’imposta di successione basandoci su dati che dimostrano come l’80% del patrimonio dei 300 super-ricchi residenti in Svizzera è frutto di eredità, ossia di privilegi.
Se molti contribuenti facoltosi lasceranno la Svizzera, anche il gettito delle imposte sul reddito e sulla sostanza si contrarrà. Secondo uno studio di Marius Brühlart, dell’Università di Losanna, la vostra imposta sulle successioni finirà addirittura col provocare perdite fiscali allo Stato, anziché generare maggior introiti. Giocate col fuoco?
No. Lo studio di Brühlart, sul quale anche noi ci siamo basati, precisa che ciò si verificherà solo se non verranno adottate quelle misure per combattere l’elusione fiscale che l’iniziativa prescrive. D’altronde, non esistono studi che dimostrano la tesi di una perdita di gettito fiscale collegata alla fuga all’estero dei ricchi contribuenti. Anzi: in Ticino, nonostante un calo del numero di ‘globalisti’ [ricchi stranieri residenti tassati in base al dispendio, ndr], il gettito complessivo generato dai forfait fiscali è aumentato. I super-ricchi risiedono qui per tante ragioni (stabilità politica, manodopera qualificata, ottime infrastrutture, ecc.), non certo solo per l’aspetto fiscale.
Lo stesso Brühlart vedrebbe di buon occhio imposte sulle successioni più elevate, per aumentare il gettito fiscale e ridurre la grossa disparità esistente a livello di patrimoni. Però parla di un’aliquota del 5-10%, non del 50%; in cambio, l’importo esente da imposta potrebbe essere molto più basso, ad esempio inferiore ai 100mila franchi. Non potevate sparare un po’ meno in alto?
Vogliamo chiamare alla cassa solo le persone che approfittano del nostro sistema, quelli con una ricchezza spropositata, non coloro che ereditano 100mila franchi. Il nostro obiettivo è ridistribuire la ricchezza, ristabilire la giustizia sociale, climatica e fiscale.
Sostenete che le piccole e medie imprese (Pmi) non verranno colpite. Eppure, dato il valore non solo monetario di un’azienda, si fa relativamente presto a superare la soglia dei 50 milioni. Può capire l’ansia di un Fabio Regazzi [presidente dell’Unione svizzera delle arti e mestieri-Usam, ndr]?
La preoccupazione è infondata. Il testo dell’iniziativa è chiarissimo: la nuova imposta si applica solo alle persone fisiche, ossia a quei 2’500 super-ricchi che hanno tutti i mezzi per pagarla. Se i soldi stanno dentro l’impresa, non sottostanno alla nostra imposta. E poi quale Pmi supererebbe la soglia dei 50 milioni di franchi? Nel 2015 [quando si votò su un’iniziativa della sinistra per introdurre un’imposta di successione a favore dell’Avs, ndr], il vicepresidente dell’Usam dichiarò che con una simile franchigia non sarebbe stata colpita nemmeno una Pmi.
Intervista apparsa il 17 novembre su LaRegione.